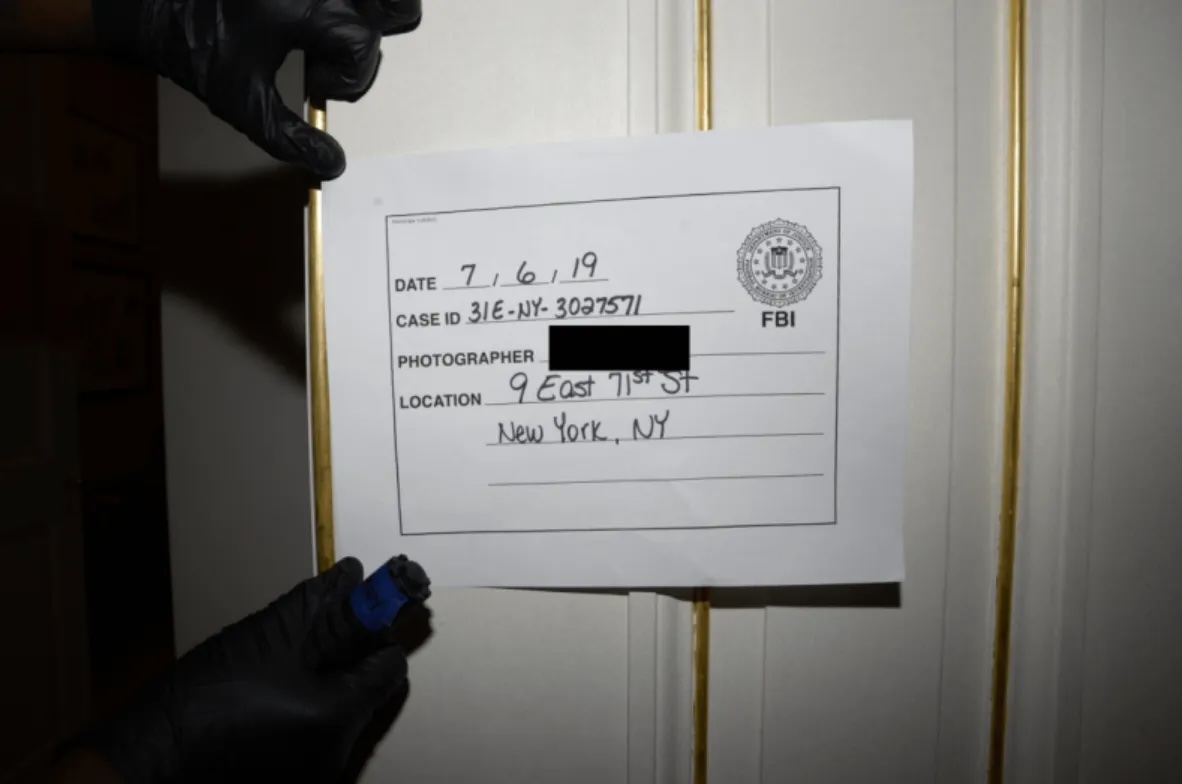Per creare coesione, bisogna partire da luoghi e persone
Intervista a Fabrizio Barca, che oggi guida il Forum Disuguaglianze e Diversità, ma che in passato ha dato un contributo importante per cercare di riformare la politica di coesione dell’Ue

Oggi Fabrizio Barca è il volto del Forum Disuguaglianze e Diversità. Il Forum DD, come viene abbreviato, è un’alleanza tra ricercatori e organizzazioni di cittadinanza attiva come Fondazione Lelio e Lisli Basso, ActionAid e Caritas Italiana, nata per “disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le disuguaglianze, aumentino la giustizia sociale e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona (diversità)”.
Il suo presente, quindi, è pienamente inserito nella società civile.
Ma il passato di Barca, o meglio, la sua «vita precedente», come scherza lui stesso, è fatto di incarichi nelle istituzioni e negli organismi internazionali.
É stato capo della Divisione ricerca della Banca d’Italia, capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, direttore generale del Ministero dell’economia e delle finanze e presidente del Comitato per le politiche territoriali dell’OCSE. Tra 2011 e 2013, ha anche svolto il ruolo di ministro senza portafoglio con delega per la coesione territoriale nel governo Monti.


A livello europeo, però, il suo nome è legato alla politica di coesione Ue, per la quale ha scritto un importante documento, informalmente chiamato proprio “Rapporto Barca”.
Il rapporto indipendente, intitolato “Un’agenda per una politica di coesione riformata”, è uscito nel mese di aprile di quattordici anni fa. Ma è ancora oggi un punto di partenza importante per ragionare, nell’ambito del progetto A Brave New Europe – Next Generation, di quanto l’Unione Europea e il nostro Paese facciano per ridurre le disuguaglianze.
Nel 2009, nel suo rapporto per la Commissione UE diceva che una riforma della politica di coesione era necessaria per “rispondere all’aspettativa dei cittadini europei che tutti, indipendentemente dal luogo in cui vivono, siano in grado di beneficiare dei vantaggi economici derivanti dall’unificazione”. Vista oggi, la politica di coesione è riuscita a contrastare le disuguaglianze?
I fondi della politica di coesione non sono stati buttati via, sono serviti. Staremmo peggio se non ci fossero. Questi fondi, però, per gli stati Ue non sono ordinari, ma straordinari e servirebbero a far cambiare traiettoria. Hanno faticato moltissimo a farlo. In prevalenza, hanno continuato a compensare la direzione presa dall’Unione Europea.
Per quanto non siano pochissimi, i fondi della politica di coesione rappresentano pur sempre una cifra intorno allo 0,4% del Pil Ue: non bastano, da soli, a fermare e invertire l’aumento delle disuguaglianze territoriali. A meno che non vengano usati per cambiare il modo in cui vengono fatte le politiche ordinarie.
Il rapporto come proponeva di farlo?
Con un approccio place-based o, meglio, come lo definiamo oggi in italiano, un approccio rivolto alle persone e ai luoghi. É un’idea di politica di coesione che dà spazio e ruolo ai livelli territoriali.
È una logica che non è né bottom up né top down. Né dal basso né dall’alto. A livello europeo e nazionale, vengono definite delle missioni strategiche che contengono principi e grandi indirizzi. Ai livelli territoriali, queste missioni strategiche trovano la loro caduta a terra, integrandosi con i saperi che i luoghi possiedono.
Quattordici anni dopo, come vede recepite quelle idee?
Rileggere oggi quel rapporto, che porta il mio nome ma è stato redatto da un gruppo straordinario di un centinaio di persone, fa una certa impressione. Per i temi che poneva, come l’inclusione sociale, la questione demografica e la sfida ambientale. Ma anche per il metodo che proponeva.
Quelle idee hanno contaminato il linguaggio, ma non sono state abbracciate dalla politica. Non aver seguito un approccio davvero place-based ha frenato l’efficacia della politica di coesione. E questo è successo perché la classe politica e dirigente europea è ancora lontana da un approccio rivolto alle persone e ai luoghi.
Che cosa intende concretamente?
I funzionari di alcune direzioni generali della Commissione Europea, così come le classi dirigenti intorno ai capi di Stato e di governo Ue sono sordi. Non ascoltano cosa hanno da dire i territori, con i loro saperi e le loro aspirazioni. Pensano che esprimano solo bisogni e sofferenza che si possono vedere nei dati e non, appunto, ascoltando le persone che vivono in quei luoghi.
Faccio un esempio concreto. In una zona interna dell’Italia, un’associazione valdese ha lavorato su come dare le terre del Comune ai giovani che vogliono tornare a fare agricoltura in quel luogo. Si tratta di una modifica di nove parole ad una normativa, che renderebbe il processo possibile e facile. Eppure questa modifica, frutto di un sapere molto avanzato che si è sviluppato in un preciso territorio, non è ancora stata fatta da nessun governo. Ogni tanto, però, in quell’area interna arrivano dei soldi, distribuiti con atteggiamento caritatevole e molto meno utili di quella modifica per i terreni ai giovani.


Questo non è un approccio rivolto alle persone e ai luoghi…
Non lo è affatto. Mi spiego meglio con un altro aneddoto. Il rapporto Barca ci era stato commissionato dalla Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione UE (DG Regio). Allora, un’altra Direzione generale, quella degli Affari economici e finanziari (DG Ecfin), scatenò contro il nostro gruppo di lavoro e il nostro approccio una battaglia fortissima.
Per funzionari e politici come questi, i soldi della coesione servono per evitare rivolte sociali, per far si che la gente non sia incazzata. Seguendo questa logica, se i fondi vengono usati male fanno dei danni devastanti sui territori. Ma, anche se vengono usati bene, non fanno danno, ma non cambiano nemmeno le cose.
A maggior ragione se un Paese fatica persino a spenderli i fondi che arrivano dall’UE. È quello di cui spesso accusano l’Italia. È davvero così?
Il fatto che spesso abbiamo avuto difficoltà nello spendere i fondi UE è vero, ma non è sempre stato così. Tra il 1997 e il 2006, in Italia si è registrato un miglioramento che ci ha portati a metà della classifica degli stati UE. E parlo solo banalmente di spesa, che è un primo indicatore.
Durante il secondo e il terzo governo Berlusconi (tra il 2001-2006, quando Barca era Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, ndr) regioni come Campania, Puglia e Basilicata hanno fatto riforme che non sarebbero mai potute avvenire senza i fondi UE. La loro erogazione, infatti, venne legata in modo molto stringente a un rinnovamento dell’assetto amministrativo delle regioni. Poi le cose son peggiorate, perché gestite peggio.
Oggi, ci sono Regioni, al nord come al sud, che hanno raggiunto livelli di utilizzo dignitosi e positivi. È una mappa molto diversificata. E poi c’è il livello ministeriale, dove ci sono esempi di risultati notevolissimi nell’utilizzo dei fondi. Penso, per esempio, al Ministero dell’Istruzione.
Tutto questo, con quali esiti?
Questa domanda ci riporta all’inizio. Gli esiti dipendono dall’aver scelto, oppure no, un approccio place-based. In tal senso, faccio un ultimo esempio, questa volta positivo.
Ben prima del mio rapporto sulla politica di coesione, a metà anni Novanta, anche grazie al pensiero di sociologi come Giuseppe De Rita e Aldo Bonomi, in Italia sono nate le esperienze dei patti territoriali. Non tutti hanno funzionato, ma quelli che hanno ricevuto dei fondi UE (e che quindi sono stati chiamati patti comunitari) hanno prodotto dei risultati interessanti.
Oggi, in Puglia, in Campania, in Sicilia, ci sono zone dove le cose vanno meglio, dove c’è più vivacità, legalità, trasparenza e occupazione. Guardando indietro, si scopre che sono proprio le zone dove 20, 25 anni fa l’uso dei fondi della politica di coesione all’interno dei patti comunitari ha fatto emergere una classe dirigente.
La foto in apertura è di Lucio Colavero
![]() UN PROGETTO DI SLOW NEWS, PERCORSI DI SECONDO WELFARE, INTERNAZIONALE, ZAI.NET,
UN PROGETTO DI SLOW NEWS, PERCORSI DI SECONDO WELFARE, INTERNAZIONALE, ZAI.NET,
LA REVUE DESSINÉE ITALIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA.
Autrici e autori dei contenuti sono i soli responsabili di questa pubblicazione. I contenuti riflettono i nostri punti di vista. La Commissione Europea non è in alcun modo responsabile di come verranno utilizzate le informazioni contenute in questo progetto.