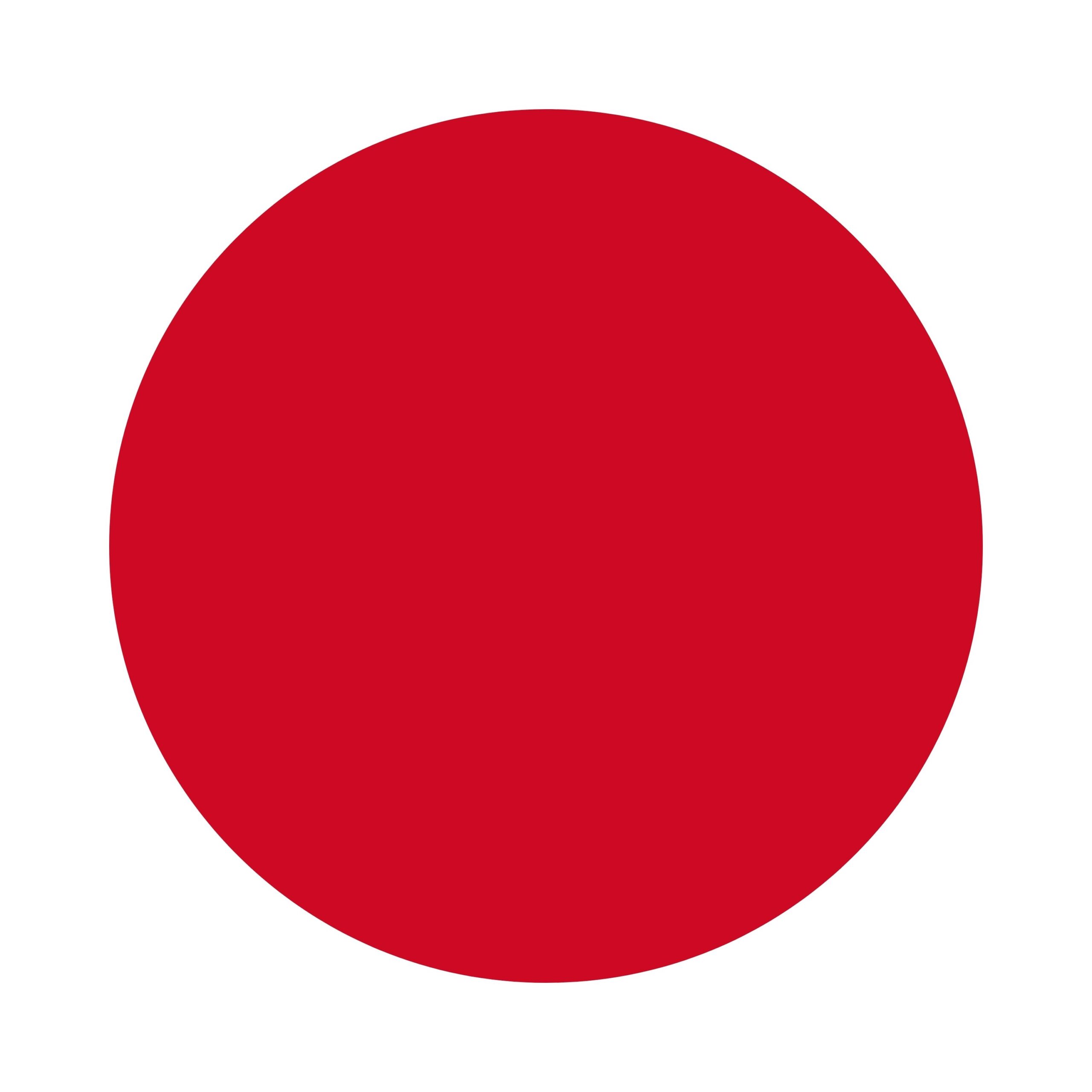Una delle cose più divertenti successe subito dopo l’invio di The Slow Journalist la scorsa settimana è che una persona mi ha mandato una mail scarnissima. C’era scritto solo: “Disiscrivimi”. La cosa mi ha fatto sorridere e ho usato l’aneddoto per un po’ di animazione sui miei social.
Allo stesso tempo, Valentina mi ha scritto: «Che bel numero: da tenere nel cassetto e non cancellare o dimenticare mai». E Piervincenzo: «Questa della gentilezza è la più bella e interessante newsletter che ho letto finora. Credo di averle lette tutte da un anno circa a questa parte. Soprattutto per quanto riguarda la gentilezza non stucchevole e non formale» (puoi scrivermi anche tu, qui)
Nella conversazione social, invece qualcuno mi ha fatto notare che ci sono altre parole oltre a gentilezza, che dovrebbero essere approfondite. Tra di esse, relazione e cura – che sono quelle cose che le macchine, oggi, non possono replicare, come ho scritto qualche tempo fa – e poi un’altra parola, bella ma difficile: conflitto.
Il conflitto viene negato, e non è necessariamente un bene. Non sto parlando di guerra, di scontri armati, no. Sto parlando di conflitto nel senso che esistono interessi contrapposti fra persone, gruppi di persone, classi.
Lavorando al nuovo episodio del podcast Slowly (si ascolta qui) è venuto fuori che la negazione del conflitto è uno dei temi portanti di un pezzo del racconto giornalistico, ma anche della conversazione nell’infosfera. Così, per esempio, si condannano senza appello le persone che adottano metodi di protesta che non condividiamo (si vorrebbero proteste silenziose, tranquille, che non danno fastidio. Dunque, invisibili). Non solo.
Negando il conflitto si avalla anche la riproduzione delle diseguaglianze e dei temi cari alla cultura dominante.
Pensa a quel che è successo sulla storia della collaboratrice scolastica pendolare Napoli-Milano. È una storia che ha sicuramente una sua rilevanza per la protagonista, che ora si trova oggetto di attenzioni indesiderate.
Non voglio parlare dello statuto di verità della storia in sé. Do per scontato che siamo d’accordo sul fatto che giornalismo è metodo della verifica prima ancora che racconto.
Vale giusto la pena di dire che, dopo la prima pubblicazione, il Giorno cavalca la storia con pezzi corollari, giustamente dal loro punto di vista; ci sono fact-checker veri o improvvisati (utenti del web, come li chiama alcuni) che si sono messi a fare i conti, anche se il punto di partenza del loro ragionamento sembra essere: questa storia non può essere vera, quindi è falsa. In effetti, facendo i conti da casa sembrerebbe proprio così, eppure la protagonista conferma tutto. Vero? Falso? È lei che ci marcia? Vuole solo trovare una stanza?
Ecco. Dimentichiamoci tutto questo.
Ci sono altri temi che mi stanno molto a cuore e che dovrebbero starci a cuore
– gli effetti indesiderati (ma prevedibili) di questa storia. Ci sono effetti indesiderati desiderabili (per esempio: se la protagonista trovasse una sistemazione consona, o un lavoro più vicino). E ci sono effetti indesiderati per nulla desiderabili:
- l’inquinamento dell’infosfera con una conversazione polarizzata e tifosa
- le conseguenze sulla vita della persona protagonista della storia, che si trova ad essere indagata, investigata come se avesse fatto chissà cosa, esaltata da alcuni come paladina, dileggiata da altri, comunque posta sotto la lente di ingrandimento. A questo proposito, ti ricordo che qui la comunità di The Slow Journalist ha tradotto una guida per persone che dovranno essere intervistate. Si intitola: così vogliono intervistarti e si può diffondere liberamente
Il giornalismo non pensa quasi mai agli effetti indesiderati. Soprattutto quando si occupa di persone comuni, ma a volte anche quando si occupa di persone che hanno rilevanza nella sfera pubblica. Questo non significa che si debbano occultare i fatti. Ma pensar prima alle conseguenze che avranno le nostre storie (su protagonistə e sulla società) è comunque importante ed è un atto di cura e relazione.
– le motivazioni che rendono questa storia “notiziabile”: è un’eccezione, un aneddoto, un assurdo
– il framing nel quale si inserisce: idolatria del lavoro e del sacrificio (qui trovi framing nel glossario di Slow News), riproduzione delle disuguaglianze, mantenimento dello status quo per le élite
– la rilevanza sociale del racconto. Ne avrebbe, o meglio, ne avrà, se fosse usato come filone per un nuovo framing: ricordarci che non è vero che ci si deve sacrificare per il lavoro. Ricordarci che esiste un conflitto fra le persone che si devono sacrificare per lavorare e quelle che hanno tutto. Ricordarci di prenderci cura di queste persone e di noi stessə come comunità
Temo che non succederà, ma voglio essere possibilista. Anche se ho la sensazione che tutte queste risorse sono sprecate perché si concentrano solamente sull’aneddoto che si brucerà fra un paio di giorni. Forse è già bruciato.
Nel frattempo, la categoria “giornalista” continua a essere fra le categorie che godono di meno fiducia come ricorda il solito Edelman Trust Barometer.